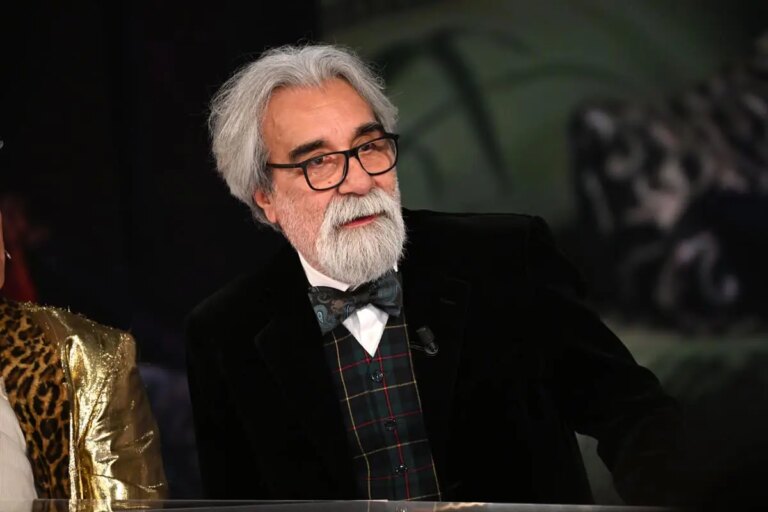SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I rappresentanti di otto imprese cinesi e italiane hanno scambiato accordi di cooperazione all’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), che è in corso questa settimana a Shanghai. Più di cento rappresentanti dei mondi politico e imprenditoriale dei due Paesi hanno assistito a questo momento. Le imprese alimentari e di prodotti agricoli caratteristici cinesi e italiane hanno stretto nuove connessioni attraverso la CIIE, aprendo insieme un nuovo capitolo di cooperazione.
Nel corso del “China-Italy Business Matchmaking” dell’ottava CIIE, tenutosi il 6 novembre al National Exhibition and Convention Center di Shanghai, circa venti aziende alimentari italiane, tra cui Inalpi, hanno tenuto discussioni in loco, sessioni di matchmaking e scambi con oltre dieci acquirenti cinesi, tra cui Mengniu Dairy Company Limited e JD.com, delineando un quadro vivace di integrazione, cooperazione e creazione congiunta del futuro tra le imprese dei due Paesi.
Secondo Chang Min, presidente della BRIFF Italian Food and Feed Promotion, tra le aziende italiane partecipanti al CIIE di quest’anno ci sono sia noti produttori europei di latticini sia
piccole e medie imprese, coprendo prodotti come bevande alcoliche, prodotti da forno e alimenti salutistici. Tra queste, quattro imprese sono specializzate nel cibo per animali. Tali aziende sono ottimiste riguardo il rapido sviluppo del mercato cinese dell’economia legata agli animali domestici e sperano di cogliere opportunità di business nel mercato cinese in forte espansione e condividere i benefici dello sviluppo tramite la piattaforma aperta della CIIE.
Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi S.p.A., che sta partecipando per la seconda volta alla CIIE, ha dichiarato che l’azienda ha portato quest’anno due tipi di prodotti: quelli a uso industriale e quelli destinati al consumo. Invernizzi ha affermato: “Nonostante i dazi esistenti e le frizioni geopolitiche, la nostra cooperazione con i partner cinesi è sempre stata fluida. L’anno scorso l’azienda ha ricevuto riscontri molto positivi alla CIIE e quest’anno puntiamo a costruire una rete di cooperazione più matura e progetti più sostanziali”.
Sacco System è un’impresa biotecnologica che produce ingredienti microbici e probiotici per i settori alimentare e della salute. Viola Verga, La consigliera di amministrazione dell’azienda, ha spiegato: “Quest’anno è la nostra prima partecipazione alla CIIE. Anche se non portiamo prodotti tangibili, consideriamo questa esposizione un’opportunità chiave, un ponte tra Italia e Cina”.
Secondo Verga, la crescente domanda dei consumatori cinesi per prodotti salutari e naturali è perfettamente in linea con la filosofia di Sacco System. “I nostri ingredienti supportano alimenti ‘clean label’, naturali e funzionali, che sono esattamente le tendenze che stanno plasmando il mercato cinese”, ha sottolineato.
“La CIIE ci permette di entrare in contatto non solo con potenziali partner commerciali, ma anche con istituti di ricerca e agenzie governative”, ha aggiunto. “Questo è l’inizio di un dialogo di lungo periodo”.
In quanto prima esposizione al mondo di livello nazionale dedicata alle importazioni, la CIIE funge da “grande palcoscenico” per osservare da vicino l’apertura di alto livello della Cina e da “zona esperienziale” per percepire in maniera immersiva i vantaggi del suo mercato di larga scala. L’esperienza dell’ottava edizione della CIIE ha dimostrato pienamente che il grande mercato cinese si sta trasformando in maniera efficace in una grande opportunità per il mondo intero.
(ITALPRESS).