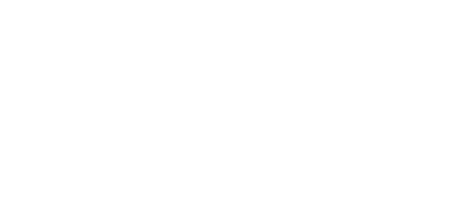Schifani “Crisi imprevista, ma andiamo avanti con ferma determinazione”
PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile. Ma nelle mie scelte ha prevalso l’esigenza della tutela della legalità e trasparenza del Governo e delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e chiede il mio governo. Un governo che deve andare avanti. I dati di Banca d’Italia confermano come siamo nella buona strada. Cresce l’economia, crescono i posti di lavoro, crescono le entrate, crescono gli export, e cresce il turismo. Andiamo avanti con ferma determinazione e anche con coraggio”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. vbo/mca1/gtr
(Fonte video: Facebook Renato Schifani)
Schifani “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista. Avanti con ferma determinazione e coraggio” / Video
PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile. Ma nelle mie scelte ha prevalso l’esigenza della tutela della legalità e trasparenza del Governo e delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e chiede il mio governo. Un governo che deve andare avanti. I dati di Banca d’Italia confermano come siamo nella buona strada. Cresce l’economia, crescono i posti di lavoro, crescono le entrate, crescono gli export, e cresce il turismo. Andiamo avanti con ferma determinazione e anche con coraggio”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Polizia locale, consegnati droni e attestati da pilota a 94 comuni del Lazio
ROMA (ITALPRESS) – “Le Polizie locali del Lazio continuano a crescere e oggi sono un modello per l’Italia intera: oggi in Regione abbiamo consegnato i droni e i diplomi agli agenti delle Polizie locali dei 94 Comuni del Lazio che hanno partecipato al corso professionalizzante per pilota di drone al quale si poteva partecipare attraverso il bando “Polizia Locale 4.0″. Attraverso questi strumenti innovativi garantiamo alle comunità locali un controllo maggiore e più capillare del territorio: grazie ai droni, infatti, sarà possibile monitorare meglio il territorio e scoprire illeciti altrimenti difficilmente individuabili”. Lo dichiara l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti. “Questi strumenti tecnologici sono fondamentali per individuare roghi tossici, abusi edilizi, illeciti ambientali, discariche ed insediamenti abusivi, gestire grandi eventi. Il nostro unico obiettivo è quello di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini: potenziare le Polizie locali significa rafforzare il primo presidio di legalità e sicurezza sui territori”, aggiunge l’assessore Regimenti.
“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai partner che hanno permesso di portare a termine questo corso, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e le scuole di volo che hanno contribuito a formare i nostri agenti. Questo corso è un esempio positivo di come la collaborazione tra Pubblica amministrazione, mondo accademico e privati può portare un valore aggiunto per la collettività. Oggi la sicurezza dei territori passa per le nuove tecnologie. Continueremo a lavorare in questa direzione con il progetto Lazio Sentinel 2030 grazie al quale doteremo i territori di strumenti di ultima generazione – telecamere intelligenti, colonnine SOS, sistemi di gestione dei flussi video con IA e altre innovazioni – per aiutare i nostri agenti a garantire un servizio sempre più efficiente a tutela dei cittadini”, conclude l’assessore Luisa Regimenti.
– foto ufficio stampa Regione Lazio –
(ITALPRESS).
Webuild, Salini ad Assemblea Federacciai “Sinergia vitale per l’industria”
ROMA (ITALPRESS) – Webuild si conferma tra i maggiori acquirenti di acciaio in Italia, sostenendo direttamente la produzione e l’occupazione del settore. Nel solo triennio 2023–2025, il Gruppo ha superato gli 800 milioni di euro di acquisti di acciaio in Italia. Il dato è stato reso noto nel corso dell’Assemblea Pubblica di Federacciai, svoltasi a Bergamo, alla quale ha partecipato l’amministratore delegato del gruppo, Pietro Salini. Salini ha ricordato come l’industria siderurgica e quella delle grandi infrastrutture siano asset chiave per la competitività del Paese. Per questo motivo, ha evidenziato il manager, le infrastrutture sono motore di crescita del PIL e dell’occupazione in tutti i settori collegati, ma per sprigionare questo potenziale ”serve un’industria italiana solida e competitiva a livello globale”, ha affermato. Ma c’è anche bisogno, secondo Salini, di ”regole più semplici, obiettivi realistici e di una visione industriale che sostenga il sistema produttivo di fronte alla sovracapacità estera, in particolare quella cinese”. Secondo Salini serve inoltre che le grandi aziende italiane insieme alle loro filiere collaborino in modo sinergico per fare davvero sistema. Le infrastrutture sono oggi strumenti essenziali di politica economica e di geopolitica industriale. Non possiamo prescindere dall’industria siderurgica come settore strategico. Sostenere la filiera è fondamentale per garantire occupazione qualificata e per assicurare anche alle prossime generazioni le politiche di welfare di cui godiamo oggi, ha concluso l’amministratore delegato di Webuild.
abr/gtr
Salini (Webuild) “Sinergia acciaio-infrastrutture vitale per il Paese”
BERGAMO (ITALPRESS) – “L’industria siderurgica e quella delle grandi infrastrutture sono asset chiave per la sovranità e la competitività del nostro Sistema Paese. Questo legame biunivoco non è solo economico, ma è strutturale per la vita quotidiana delle persone. Spesso dimentichiamo quanto acciaio e infrastrutture abbiano trasformato l’Italia, contribuendo al suo passaggio da Paese agricolo a potenza industriale. I traguardi raggiunti nel secolo scorso non sono scontati: sono il frutto di visione e di investimenti che hanno cambiato la nostra storia”. E’ quanto ha dichiarato Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, in occasione dell’Assemblea Pubblica di Federacciai svoltasi a Bergamo.
In questa sinergia, Webuild si conferma tra i maggiori acquirenti di acciaio in Italia, sostenendo direttamente la produzione e l’occupazione del settore. Nel solo triennio 2023-2025, il Gruppo ha superato gli 800 milioni di euro di acquisti di acciaio in Italia.
“Le infrastrutture sono motore di crescita del PIL e dell’occupazione in tutti i settori collegati, ma per sprigionare questo potenziale serve un’industria italiana solida e competitiva a livello globale”, ha proseguito Salini.
“Abbiamo bisogno di regole più semplici, obiettivi realistici e di una visione industriale che sostenga il nostro sistema produttivo di fronte alla sovracapacità estera, in particolare cinese. Serve inoltre che le grandi aziende italiane insieme alle loro filiere collaborino in modo sinergico per fare davvero Sistema Paese”, ha proseguito Salini.
“Le infrastrutture sono oggi strumenti essenziali di politica economica e di geopolitica industriale. Non possiamo prescindere dall’industria siderurgica come settore strategico. Sostenere la filiera – seconda in Europa per volumi e prima per produzione da forno elettrico – è fondamentale per garantire occupazione qualificata e per assicurare anche alle prossime generazioni le politiche di welfare di cui godiamo oggi”.
“L’acciaio italiano, riconosciuto per qualità e durabilità, è la risorsa indispensabile per il piano infrastrutturale in corso – il più ampio dal secondo dopoguerra – e per quello futuro. L’acciaio è l’elemento portante che assicura la sicurezza e l’affidabilità di opere cruciali che ridisegnano la mobilità del Paese anche oggi – ha concluso Salini – come le nuove linee ferroviarie ad alta velocità del Terzo Valico dei Giovi, della Verona-Padova, della Napoli-Bari, della Salerno-Reggio Calabria e come l’alta capacità Palermo-Catania-Messina”.
Foto Ipa Agency
(ITALPRESS).
‘Ndrangheta, confiscati beni per 830 mila euro a esponenti cosca “Trapasso” di Cutro
CATANZARO (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con cui è stata disposta la misura ablativa, in via definitiva, di 8 unità immobiliari e di 2 rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre 830 mila euro, all’esito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di 3 esponenti di rilievo della cosca “Trapasso” di San Leonardo di Cutro (KR).
I prevenuti, nell’anno 2016, erano stati coinvolti nell’operazione “Borderland” della Direzione Distrettuale di Catanzaro, in quanto figure di primo piano del sodalizio mafioso operante a San Leonardo di Cutro (KR), inserito nella locale di Cutro (KR) facente capo ai “Grande Aracri”, dedito prevalentemente alle estorsioni nei confronti di imprenditori operanti nel settore turistico.
-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-
(ITALPRESS).
Condotte 1880 costruirà la nuova linea ferroviaria in Uganda
ROMA (ITALPRESS) – La società di costruzioni Condotte 1880, guidata dal professor Valter Mainetti, è in dirittura d’arrivo per finalizzare, in consorzio con imprese italiane specializzate nel settore, il contratto con l’Uganda per la realizzazione “chiavi in mano” di una nuova linea ferroviaria di 62 km. Questa infrastruttura collegherà Tororo, un importante nodo ferroviario situato vicino al confine con il Kenya, con Majanji, una città nella regione orientale sul Lago Vittoria, dove è prevista la costruzione di un porto destinato principalmente al traffico merci. Infrastruttura strategica per il progresso del Paese africano Condotte 1880 provvede alla progettazione e costruzione dell’infrastruttura, ritenuta strategica dal governo ugandese per il progresso economico del Paese. L’opera rivestirà un ruolo cruciale nel facilitare gli scambi commerciali con i Paesi confinanti, in particolare con il Kenya e il porto di Mombasa, che rappresenta per l’Uganda, priva di sbocchi sul mare, un accesso fondamentale ai traffici marittimi.
“Sono orgoglioso – ha affermato Valter Mainetti, Presidente e Amministratore Delegato di Condotte 1880 – di poter contribuire alla realizzazione di un’infrastruttura molto importante per l’Uganda, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita anche recentemente in Algeria, dove stiamo ultimando una ferrovia di 130 km con numerosi viadotti e gallerie. Sono anche onorato di intervenire in un Paese con il quale, dal 1974, l’Italia intrattiene stretti rapporti di cooperazione. Questo progetto rappresenta non solo un’opportunità di crescita e sviluppo per l’Uganda, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione internazionale possa favorire il progresso e il benessere delle comunità locali”.
Al consorzio “made in Italy” partecipano oltre Condotte 1880, a cui competerà il 65% del valore totale del progetto di 650 milioni di dollari, Salcef Group per gli impianti ferroviari ed elettrici, Progress Rail/Caterpiliar – Italia per la segnaletica e la sicurezza ferroviaria e Almaviva per le tlc e le infrastrutture digitali. “La nuova ferrovia, che comprende anche 6 stazioni, sarà realizzata – ha spiegato Ugo Cozzani, Vicepresidente di Condotte 1880, responsabile estero – in parte attraverso il montaggio e la posa in opera di strutture prefabbricate costruite in loco, comprese le traversine ferroviarie. Il personale che verrà occupato sarà, inoltre, formato appositamente, anche per livelli dirigenziali, in una Accademia di Formazione Ferroviaria, che il consorzio si impegna a istituire presso l’Università Busiterna di Tororo”. Il finanziamento del progetto, che si prevede sarà definitivamente approvato entro dicembre 2025, sarà coordinato da CityBank e godrà della garanzia sovrana del Governo dell’Uganda, che parteciperà anche direttamente con il contributo del 15%. Fra i finanziatori dell’opera è previsto anche l’intervento italiano attraverso Cassa Depositi e Prestiti, la Sace e Simest.
– foto ufficio stampa Condotte –
(ITALPRESS).
Eni, Descalzi “In Libia siamo essenziali”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In Libia Eni si sente “in una situazione abbastanza sicura” in merito alla “mitigazione del rischio sui progetti che stiamo sviluppando”. Lo ha affermato l’amministratore delegato, Claudio Descalzi, parlando con i giornalisti a Wall Street, dopo la cerimonia della campanella per celebrare i 30 anni di quotazione al New York Stock Exchange.
“In Libia produciamo gas che va tutto al Paese, questo ha permesso loro di passare dal carbone al gas – ha aggiunto -. Siamo diventati essenziali e questo ci ha permesso di salvaguardare la nostra produzione. Li stiamo aiutando, stiamo investendo, siamo gli unici investitori nel Paese per qualcosa che serve a loro”.
xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)