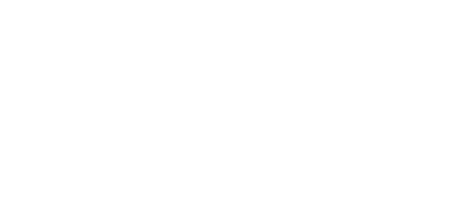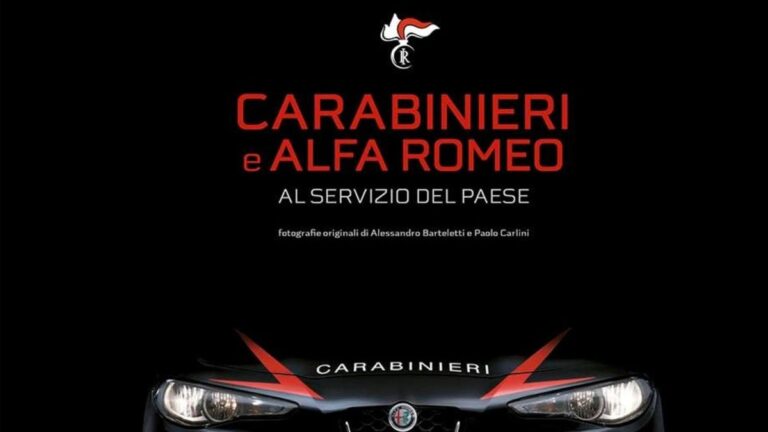ROMA (ITALPRESS) – Un boato di felicità e liberazione ha accolto all’alba la notizia della scarcerazione di Alberto Trentini e Mario Burlò in America Latina ed in Italia.
A Venezia le campane hanno risuonato a festa in tutte le chiese svegliando la città. Grandissime la commozione, la felicità e le lacrime di gioia dei genitori di trentini, Armanda Colussi ed Enzo Trentini che dopo 423 giorni di angoscia hanno potuto parlare col figlio, che si trovava in sicurezza all’Ambasciata d’Italia a Caracas. L’aereo che lo riporterà a casa è già decollato da Ciampino.
Colllaboratore dell’organizzazione non governativa Humanity & Inclusion, Trentini era stato arrestato il 15 novembre 2024 mentre viaggiava da Caracas a Guasdualito. La conferma ufficiale della sua detenzione era stata fornita all’Ambasciata d’Italia solo dopo due mesi. Prima di Alberto Trentini era liberato Mario Burlò, imprenditore piemontese detenuto dal novembre 2024 con generiche accuse di terrorismo dopo essere entrato via terra dalla Colombia. Burlò che in carcere ha conosciuto Alberto Trentini ha raccontato numerosi particolari della detenzione di entrambi.
“Nel penitenziario Rodeo – ha affermato – si stava sempre nella cella, tranne un’ora al giorno per andare al corridoio esterno dove si vede il cielo. Per portarti lì le guardie ci ammanettavano e mettevano un cappuccio sulla testa. Quando è arrivato, Alberto era sconvolto. Io e lui avevamo attacchi di ansia, per cui il servizio infermeria ci dava delle pillole antidepressive. Ma Mario era più controllato e riusciva a rimanere calmo”. Burlò, che è dimagrito 30 chili, descrive le celle come “un freezer d’inverno e un forno d’estate. Le zanzare ci divoravano. Ogni cella misura quattro metri per due, che diventano uno perché su un lato c’è la branda a castello. Ci sono sei passi dalla porta al fondo. Mentre “il bagno é un buco per terra, sporco di feci e infestato di scarafaggi”.
La Farnesina, sta facendo pressioni per la liberazione di tutti gli altri 20 italiani detenuti in Venezuela. La liberazione dei detenuti politici stranieri segna una parziale evoluzione nel tentativo di normalizzazione della neo Presidente ad interim Delcy Rodriguez.
LA SODDISFAZIONE DI MELONI
“Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
TAJANI “TRA STASERA E DOMATTINA TORNERANNO IN ITALIA”
“Trentini e Burlò sono liberi e stanno bene”. Lo ha confermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Sky Tg24. “Ho parlato con loro, appena arrivati nella sede diplomatica italiani a Caracas. Li ho trovati su di morale e siamo felici di questo risultato ottenuto, frutto di un grande lavoro sottotraccia con la famiglia, il presidente del Consiglio e la rappresentanza diplomatica. La svolta è arrivata ieri sera quando mi ha chiamato il ministro degli esteri del veneziela per annunciarmi che la decisione era stata presa. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo, la decisione della presidente Rodriguez di avviare una nuova stagione con la liberazione dei detenuti politici è uan decisione che crea un nuovo clima nelle relazioni tra Venezuela e l’Italia”. Tajani annuncia che “è già partito un aereo da Roma e tra stasera e domani mattina Trentini e Burlò saranno nel nostro paese”.
LE REAZIONI
“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. A nome mio personale e del Senato della Repubblica ringrazio il governo italiano, le autorità venezuelane e chi ha operato nell’ombra e nel silenzio per arrivare a questo importante risultato”. Così sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
“La notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, che segue quella di altri connazionali nei giorni scorsi, è motivo di profonda gioia. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).