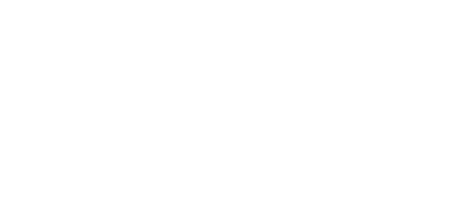Bertesina, località a qualche chilometro dal capoluogo, vanta nel suo territorio la presenza di villa Chiericati – Ghislanzoni del Barco – Curti, le cui prime notizie risalgono al 1502, riportate da Marco Antonio Sabellico nel suo Crater vicentinus, dove accenna – forse con eccessiva generosità – a «doviziosi ostel» qui posseduti dai Chiericati. Nel 1560 Valerio, figlio di quel Girolamo che una decina d’anni prima aveva commissionato a Palladio l’omonimo palazzo in città, cedette la possessione ai Ghislanzoni, detti anche «Gislanzoni», che poi nel 1864, a loro volta, la trasferirono alla famiglia Curti, attuale proprietaria.
I Ghislanzoni fuggirono da Milano all’epoca della lotta fra i Visconti e i Della Torre e si rifugiarono a Barco, località presso Lecco, che aggiunsero al cognome. Un ramo della famiglia rimase lì radicato. Ne fu esponente di spicco Antonio (1824-1893), poeta e scrittore, noto, soprattutto, per aver composto, nel 1872, il libretto dell’Aida di Giuseppe Verdi, col quale collaborò anche alla revisione della Forza del destino e del Don Carlos.
Un altro ramo, invece, si trasferì a Venezia, da dove iniziò la marcia di avvicinamento a Vicenza. Primo passo fu proprio l’acquisto della possessione di Bertesina. Fu solamente intorno alla metà dell’Ottocento che i Ghislanzoni divennero vicentini a tutti gli effetti, allorché ereditarono dalla famiglia Braschi alcune case in corso Palladio-angolo corso Fogazzaro, che provvidero a riedificare su disegni di Giovanni Miglioranza (1798-1861). Ulteriori prove della loro acquisita vicentinità sono la cappella n. 97, intestata alla famiglia Gislanzoni-Brasco, presso il Cimitero maggiore, e il terzo banco di sinistra nella chiesa di San Lorenzo, che riporta, quale offerente, il nome
del «Nob. Filippo Gislanzoni Brasco», con la morte del quale, l’11 ottobre 1878, la famiglia si estinse. Per quanto riguarda l’aspetto architettonico, vari interventi hanno interessato la villa, risultato di accorpamenti e trasformazioni di edifici preesistenti. L’ultimo e più radicale ha interessato il prospetto principale, promosso dai fratelli Bernardo, Filippo e Francesco Ghislanzoni, figli di Nicola, conclusosi nel 1764, come attesta l’iscrizione in facciata.
Non documentato il nome dell’architetto-artefice: la critica (Cevese 1971 e 1980) lo ha individuato nel multiforme ingegno del bassanese Antonio Gaidon (1738-1829). Un personaggio che fu sì architetto, ma anche naturalista dilettante, studioso e precursore della moderna geologia, interessato alla meccanica e alle costruzioni in generale. Un tipico rappresentante, insomma, dell’imperante clima illuminista, una figura tutt’altro che di secondo piano, recentemente messa a fuoco e rivalutata (Brotto Pastega 2010).

La facciata si apre su un’ampia corte, delimitata a sud-ovest dal prospetto di un edificio sviluppato a L, scandito da semicolonne tuscaniche, e da un lungo muro di cinta, alleggerito da una ringhiera a stanti verticali. Il settore centrale presenta, al piano terra, un portico dorico a tre intercolumni. Un robusto marcapiano sottolinea il passaggio ai registri superiori, in ciascuno dei quali sono collocate tre finestre, in asse con i sottostanti vuoti, con sovrapposti frontoncini alternativamente triangolari e curvilinei.
Conclude il prospetto uno svettante frontone, coronato da statue, nel cui timpano campeggia lo stemma Ghislanzoni. Nei corpi laterali del piano terra, a fianco di due finestre architravate, si aprono altrettanti ampi e robusti archi a tutto sesto, a cornice bugnata di alterna lunghezza e teste manieriste in chiave di volta, intersecanti il marcapiano.
A riprova che l’intervento settecentesco è stato condizionato da preesistenze, l’architetto, per imprimere alla facciata una simmetria inconciliabile con la irregolarità della pianta, è stato costretto ad accecare l’arco di destra per non sacrificare la stanza nell’angolo sud est. La sommità del fianco occidentale si caratterizza per la singolare loggetta, ritmata da colonnine di ordine tuscanico, fra le quali si inserisce una balaustra a pilastrini cinquecenteschi, probabilmente recupero di prece-ente struttura.
A lati del corpo della villa si sviluppa, ad occidente, una lunga barchessa con portico a colonne tuscaniche, che alla estremità ripiega verso sud e separa il complesso dal paese. Struttura quasi certamente costruita dai Ghislanzoni: lo attestano due loro stemmi, uno scolpito nell’architrave di una porta che si apre nella barchessa con l’anno 1570 (probabile fine lavori), l’altro, collocato all’esterno, nel timpano del frontone che conclude il manufatto a ovest. A est, a far da pendant, si sviluppa una serra, realizzata a fine Ottocento dalla famiglia Curti.
Originali sia i serramenti e sia le porte: ma quello che è straordinario è il ficus repens che avvolge completamente le pareti, formando una sorta di galleria. È ancora quello piantato a fine Ottocento e si sviluppa da un unico ceppo: una vera meraviglia vegetale, conservatasi grazie alla cura e all’amore dei proprietari. Gioiello botanico è anche la ultracentenaria magnolia che sta di fronte, messa a dimora nel 1890, in occasione delle nozze di Domenico Curti, acquirente della villa nel 1864, con Lucia Giaconi Bonaguro.
L’edificio è circondato da un parco di quattro ettari, nel quale si ergono querce, magnolie, cedri del Libano e un viale di carpini già presente in mappe napoleoniche. Sarà anch’esso orchestrazione del ricordato Antonio Gaidon in veste di botanico-naturalista? E nel parco avevano i loro furtivi incontri d’amore Ausonia Curti e Giuseppe Tonini – propiziati dalla fedele governate Pina – la cui vicenda è contenuta in un ricco epistolario, pubblicato alcuni anni orsono. Nettamente staccata, la colombara – anch’essa frutto dell’intervento conclusosi nel 1764 – che si caratterizza per il motivo delle due lesene a fianco dell’arco.
Ricca la statuaria, attribuita alla mano di Giovanni Battista Bendazzoli (Verona 1739-Thiene 1812), artista ancora ligio ai canoni barocchi e rococò ed eseguita in occasione dell’intervento conclusosi nel 1764. Tratto dalla mitologia il repertorio: le statue di Ercole e Onfale accolgono il visitatore all’attuale ingresso, mentre nell’altro, ora in disuso, si ammirano quelle di Minerva e Mercurio. Di fronte alla facciata si dispongono, invece, le statue della Primavera, dell’Estate, dell’Autunno e dell’Inverno. All’interno è custodito uno straordinario Cristo in pietà, scultura tardo-quattrocentesca, capolavoro che, per la verità, nulla c’entra con la villa.
Proviene, infatti, dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Sovizzo basso, risalente all’ultimo quarto del Trecento, sciaguratamente abbattuta tra il 1938 e il 1940 per essere sostituta dall’attuale, eretta dalle fondamenta in forme neoromaniche su progetto dell’ingegner Fontana. Giovanni Curti, proprietario di villa Sale Mocenigo, posta proprio di fronte alla chiesa, per salvare il manufatto da sicura dispersione, lo trasportò nell’atrio di palazzo Curti sul Corso, da dove poi è stato qui trasferito alcuni anni or sono, dopo accurato restauro, che ha permesso di recuperare parte della policromia originale.
La scultura è riferibile alla bottega dei lapicidi cognati Tommaso da Lugano e Bernardino da Como, impegnati in quegli anni, come altri conterranei lombardi e ticinesi, in cantieri vicentini e comunque a mano di artista «aggiornato indubbiamente sul nuovo clima rinascimentale» (Barbieri 1961) oramai alle porte. Si tratta di un tabernacolo o ciborio, come si evince dall’iscrizione HVMANI GENERIS REDEMPTOR, [Redentore del genere umano] che campeggia sulla porticina metallica della custodia eucaristica, fiancheggiata dalle figure di san Sebastiano e di san Rocco, protettori contro il flagello della peste. Il Cristo affiora dal sepolcro, ove è calato sino ai fianchi, sorretto da due angeli dolenti. Evidente l’assonanza di questa scultura con lo scomparto centrale del cosiddetto Trittico Pojana nella chiesa di San Lorenzo a Vicenza, con la differenza che qui le figure sono colte frontalmente.
Di Giorgio Ceraso da Storie Vicentine n. 8 giugno-luglio 2022