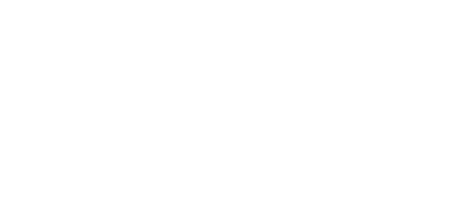Singolare e divertente, è una delle prove migliori di Virgilio Scapin il libro che raccoglie sei racconti pubblicati da Bertani nel 1976 con il titolo “I Magnasoète” e sottotitolo “I mangiatori di civette – racconti della zona di Breganze”.
All’epoca Virgilio Scapin (Vicenza, 1932-2006) aveva già al suo attivo due prove significative: Il chierico provvisorio, edito nel 1962 e Supermarket provinciale, del 1969, entrambi pubblicati da Longanesi.
La Bertani è stata una casa editrice attenta alle tematiche di politica economica e di sociologia e presentò l’opera in una collana particolare, che voleva proporre una letteratura di testimonianza “dimenticata, mai tradotta, una letteratura nascosta o che non si vuole pubblicare, ideologicamente censurata, testi che sarebbe stato difficile rivedere in circolazione” (racconti, memorie, testimonianze, ballate, poesie e interviste”: dalle “Memorie di Garibaldi” alla “Guerriglia Tupamara” a “Testimonianze su Pietro Valpreda”, per citare alcuni titoli).
Ma come mai il lavoro letterario di Scapin si inseriva in questo contesto, in questa particolare nicchia letteraria? La sua è una rappresentazione della realtà quanto mai veritiera e genuina, non ha nulla di irriguardoso, né di sovversivo. Racconta le vicende di Firmino, un contadino piccolo proprietario, tratteggiate “in successive monografie o variazioni sul tema”, come sottolinea nell’introduzione Fernando Bandini.
Lo fa “con profonda cordialità e simpatia” e alla maniera di un “antico mariazo pavano” ovvero quel tipo di farsa popolare in dialetto, in uso nel repertorio dei saltimbanchi del XV e XVI secolo, che aveva per argomento amori, matrimoni e scene di vita coniugale d’ambiente villereccio.
Firmino è un personaggio chiave nella memoria storica di Scapin, un contadino che affonda le sue radici tenacissime nella cultura della terra, nei riti di un paese agricolo, in un’epoca dominata dalla povertà e anche dalla fame. È una letteratura di testimonianza di un’epoca e di un’area geografica precisa, la vecchia Breganze con le sue colline coltivate a vigneti e frutteti, raccontata in forma diretta, quasi autobiografica. Non è una nostalgica rievocazione della civiltà contadina.
Il primo racconto, “La fiora”, descrive il fidanzamento, il matrimonio e le prodezze amorose di Firmino, giovane contadino purosangue e alpino, detto “testa de panocia” perché biondo di capelli, con la sua Pina. “La prete” racconta di una vitellina nata da un incrocio sperimentale ma promettente, con il pelame scuro come la tonaca del prete e perciò è chiamata “la prete”.
Il “Vedàto” – ovvero la botticella per il vino di casa – narra storie di viti, vendemmie e di un arciprete (realmente esistito, mons. Scotton, che costruì un prototipo di cannoncino anti- grandine presentato al popolo durante la visita del patriarca di Venezia).
E ancora “Storiette di caccia” (attività praticata anche nei periodi in cui era proibita, per necessità di sopravvivenza e con tutti i mezzi, compresa la fionda e il vischio) e storiette di “naia”, la leva militare obbligatoria, che era un vero rito di iniziazione alla maturità per la “maschia gioventù” (per citare un altro libro di Scapin edito nel 1998).
All’epoca dei racconti è in atto il cambiamento epocale per i proprietari dei piccoli poderi agricoli: la mezzadria sta scomparendo e nascono le cantine sociali. È una razza in via di estinzione, negli anni in cui il benessere economico sta modificando i riti sociali e soppiantando le antiche tradizioni contadine e paesane.
Singolare è il linguaggio, intercalato con termini dialettali propri della zona di Breganze, il dialetto che si inserisce come lingua e risponde a una “immediata esigenza di fisicità”. Scapin è uno scrittore ruspante, così lo definisce Bandini, che racconta del contadino veneto il cui dato portante è “la coprolalia e il tratto osceno, un mondo che vede nel sesso un momento di sotterfugio e di riso, proprio perché educato in un clima religioso repressivo”.
È una civiltà agricola dalla vita grama e difficile, elementare e povera, come anche la rievoca Ermanno Olmi nel film “L’albero degli zoccoli”, fatta per vivere con la terra e per la terra, un’umanità sana e genuina, vista dall’autore con uno spirito goliardico, alla maniera di Ruzzante, non priva di sollazzi e ilarità. Il libro è stato successivamente ripubblicato nel 1996 da Neri Pozza con il titolo infelicemente italianizzato ne “I mangiatori di civette”. Per questi uomini Scapin ha coniato il nomignolo “magnasoète” come una categoria sociale con i suoi riti speciali (e in effetti l’andar per nidi di civette, fin da ragazzini, era uno degli aspetti della caccia di frodo, non per divertimento ma per fame: in quell’epoca “la caccia era il raccolto più lungo dell’anno”).
Lo ha fatto perché ha voluto traslare in un termine lo spirito vivo contenuto nella parlata locale, come coniando un nome proprio per quei tipi irregolari ma di sani valori, e lo fa scherzosamente, così come nel basso vicentino si chiamano in tono canzonatorio “pinciaoche” i tipi strani e burloni protagonisti dei più folcloristici e genuini racconti dell’ambiente di campagna.
“I Magnasoète” resta nella produzione di Virgilio Scapin il testo in cui ha testimoniato in maniera più profonda l’anima della sua terra.
Di Lucio Cestonaro da Storie Vicentine n. 11 novembre-dicembre 2022