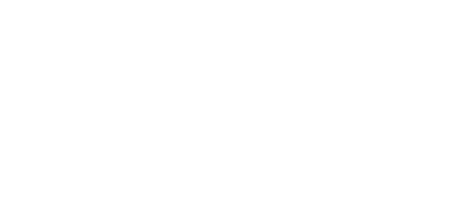Le donne partigiane combatterono la guerriglia armata, giustiziarono spie, guidarono gruppi di uomini all’assalto, vissero i mesi della montagna, torturate dai fascisti non parlarono. Le testimonianze raccolte sui supplizi subiti dalle resistenti vicentine. Nel dopoguerra taciuti come una vergogna, per decenni.

In una società con molte ferite, tra qualche giorno ricorrerà il 76° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ancora senza le cerimonie ufficiali. Io ho pensato di ricordare comunque una parte di quella Resistenza, le donne, le partigiane che hanno lottato e sofferto per la nostra libertà e i nostri diritti. Voglio inserire un piccolo ricordo su alcune di loro. Vorrei iniziare con “Maternage di massa” – Anna Bravo. Con l’armistizio dell’8 settembre 1943, alcune centinaia di migliaia di soldati italiani furono nascosti dalle donne sotto abiti civili, spesso quelli appartenenti ai propri congiunti militari: «Per di qua alpini! Per di là!» scrive Gigi Meneghello «il popolo italiano difendeva il suo esercito, visto che s’era dimenticato di difendersi da sé: non volevano saperne che glielo portassero via. Alla stazione di Vicenza fummo afferrati e passati praticamente di mano mano finché fummo al sicuro. Le donne pareva che volessero coprirci con le sottane: qualcuna più o meno provò».
In stazione a Vicenza c’era una folla di gente che cercava di aiutare i soldati italiani presi prigionieri dai tedeschi tentando di passare per quanto possibile cibarie e acqua, ma soprattutto raccogliendo i bigliettini, che venivano gettati fuori dalle finestrelle, sui quali i militari avevano scritto il nome della famiglia e l’indirizzo. Accadeva alla stazione principale, ma anche ai passaggi a livello dove il treno era costretto a fermarsi. In questo clima di solidarietà due giovani donne, Novelia Turato e Nerina Sasso persero la vita, l’11 e il 13 settembre, per un gesto di altruismo. «La mamma sentiva gridare fino a casa i ragazzi rinchiusi dentro i carri bestiame e chi li sentiva non poteva restare indifferente», racconta la figlia di Novelia, Regina Gaiola. «Guarda» disse Nerina alla sorella «c’è un treno pieno di soldati! Dai andiamo a dire loro che devono scappare altrimenti i tedeschi prendono e li portano in Germania e magari loro pensano di essere finalmente a casa». Nerina non sapeva che erano già stati catturati e che il treno aveva la scorta armata pronta a sparare su donne indifese. Invece Novelia sapeva che era pericoloso: «Lo zio diceva a mia madre di non andare perché c’erano i tedeschi che ammazzavano la gente, ma lei aveva un cuore grande ed era cocciuta». Di età diversa, entrambe avevano subito dei gravi lutti familiari che probabilmente le avevano portate ad una maggiore sensibilità verso la sofferenza altrui: a vent’anni Nerina era già orfana di entrambi i genitori, invece Novelia nel 1938 a causa di un pirata della strada che le aveva ucciso il marito, era rimasta vedova a 29 anni con due figli molto piccoli. Nerina e Novelia percepiscono tutta la tragicità di quel momento. Il giorno precedente la sua morte Nerina era andata più volte nella vicina caserma con la fedele Marcella, la domestica che aiutava in trattoria, a portare acqua, pane, uva ai soldati italiani catturati dai tedeschi: faceva molto caldo e avevano fame e sete. Novelia, operaia del lanificio Rossi che non si interessava di politica, aveva un animo grande, sempre pronta a dare una mano, e con altre ragazze aveva aiutato alcuni militari a scappare, «prendendoli a braccetto» e se li era portati a casa dove li aveva fatti cambiare d’abito, sostituendo la loro divisa con i vestiti del fratello. Novelia e Nerina non sono donne innamorate di principi astratti, ma guidate dai valori morali e ritenevano che restare umane fosse più importante che restare vive. La scelta dei valori morali non implica necessariamente che si debba sottovalutare la vita, dato che sopravvivere resta uno scopo perfettamente rispettabile, ma non a qualunque costo. Entrambe furono uccise, una in zona Ferrovieri, l’altra vicino alla chiesa di S. Maria Regina della Pace, nel tentativo di proteggere i nostri soldati, uccise dai tedeschi con le pallottole esplosive, vietate dagli accordi internazionali per gli effetti devastanti sugli esseri umani.
Le donne del battaglione Amelia. Nel Vicentino, all’indomani della Liberazione, partigiane, staffette e patriote della brigata garibaldina Stella furono inquadrate nel battaglione Amelia dal nome di battaglia di Cornelia Lovato, caduta il 28 aprile 1945.

Flora Cocco “Lea” e Wilma Marchi “Nadia” furono nominate rispettivamente comandante e commissario politico. Se la nomina fu sulla carta e a posteriori, essa rispecchiava comunque una realtà di fatto. Un consistente numero di donne aveva aderito alla resistenza in tutta la valle dell’Agno. Erano divise in gruppi e ogni garibaldina aveva il proprio compito da svolgere. Alcune confezionavano calze, altre raccoglievano lana e indumenti vari, medicinali, viveri ecc. ecc.; altre facevano la spola dal paese alle più alte contrade di montagna con sacchi di pane; altre ancora facevano le staffette da un distaccamento all’altro. Il giornale Noi Donne era letto con entusiasmo e passato con cura di gruppo in gruppo e alle riunioni, che si tenevano ora nei boschi, ora nei fienili o nelle alte contrade, partecipavano oltre 40 ragazze. Flora Cocco aveva deciso di aderire alle formazioni partigiane dopo l’uccisione del fratello Gaetano (Leo) avvenuta durante il rastrellamento della Piana (9 settembre 1944).
A Ermenegildo Rigodanzo (Catone) commissario politico della brigata Stella, che conosceva fin dai tempi del liceo, scrisse il 23 settembre 1944: «Scrivo a te come a un fratello, perché tale ti voglio considerare dacché il cielo mi ha rapito il caro Leo… Ho già espresso il mio desiderio ed ora insisto perché mi sia data presto la gioia di lavorare con voi. Guarda che io sono decisa a tutto: non importa se mi chiederai qualcosa di gravoso o pericoloso, perché sarà allora che io lavorerò con più entusiasmo». Alla fine di novembre del 1944 venne arrestata dalla brigata nera di Valdagno. «Durante il mio arresto» denunciò alla fine della guerra «fui spesso percossa e torturata: mi facevano mettere le mani in una pressa, o torchio, ed il Visonà girava la manovella affinché con lo schiacciamento dovessi parlare. Vi era poi Cracco che mi tirava i capelli». Wilma Marchi (Nadia) venne arrestata in seguito alla delazione di Maria Boschetti, Katia, e torturata: «La Wilma l’hanno picchiata così tanto» ha raccontato Luigina in una intervista «che sulla sua pelle non c’era neanche un ago bianco, erano in due. Le hanno tirato su il vestito fin sopra la testa e uno per parte armati di bastone l’hanno picchiata. Eravamo in cella insieme e l’ho vista tornare dopo le botte. […] anche con la Wilma, la bastonavano fino a quasi a farla crepare dal dolore, ma non la ammazzavano. Lei diceva: “Ammazzatemi (Copème) almeno per piacere, che sia finita!”. “No, prima di farti morire vogliamo che tu parli”. E allora la smettevano, ti buttavano una secchia di acqua addosso per farti rinvenire. Se penso a quello che hanno fatto alla Wilma mi viene da piangere ancora adesso perché la bontà di quella ragazza era infinita». Trasferita in diverse carceri, Wilma riuscì ad evadere dal campo di concentramento di Peschiera, poco prima della Liberazione.
Le donne in montagna. Fra le donne che avevano aderito alla Resistenza un certo numero viveva presso i comandi di brigata. Emilia Bertinato, staffetta della brigata Stella, mi ha raccontato nell’intervista che: “C’erano tre o quattro donne partigiane fisse, la sorella di Giglio, Anita, per me una grande amica, aveva il mitra in spalla, [ma poi c’erano] la Serena, la Maria, l’Agata, fisse là. Anche la Liliana stava fissa. Dormivano sulla tezza, là c’era il fieno. Portavano i pantaloni e il giubbetto rosso fatto dalle sarte, chissà a loro cosa sembrava, di andare chissà dove. Ce n’erano tante, non solo loro, molte da Montecchio”.
Qualcuna di loro era innamorata ed era salita in montagna per vivere la sua stagione d’amore, ma Emilia ci tiene a sottolineare che erano poche, per lo più: “C’era l’ambizione, il coraggio di un’idea …”. Certo, la promiscuità dei sessi comportava alcuni problemi per i responsabili dei distaccamenti. E infatti si legge nell’ordine del giorno di Iura, comandante della brigata Stella, datato 23 agosto 1944, che «Si è convenuto per eliminare certi scontenti verificatisi tra i vari distaccamenti, che, da oggi, tutte le garibaldine dovranno restare riunite in sede separata e svolgere quei compiti che verranno loro affidati. Oltre al lavare, cucinare e servizio di staffetta, all’arrivo del medico diverranno anche crocerossine. Con l’affluire dell’elemento donna si faranno delle vere e proprie pattuglie. Esse dovranno montare la guardia diurna, mentre verrà ad esse concessa un’ora al giorno di piena libertà, affinché possano recar visita all’uno o all’altro distaccamento. Non sarà permesso alcun contatto tra garibaldini e garibaldine durante le ore di servizio. Ai trasgressori verrà applicata quella punizione che si meritano». Alcune delle donne partigiane presenti nei distaccamenti possedevano un’arma e la usavano. “La Tamara …” mi dice Emilia “se c’era un partigiano bravo, quello era proprio lei”. Una delle più combattive è comunque Luigina Camerra, “Anita”, sorella di quattro fratelli partigiani. “Mia sorella” ha detto nell’intervista il fratello Giglio “era come un uomo con il suo mitra per traverso. Mia sorella sparava e ne ha anche colpiti. Ha partecipato anche lei armata al disarmo della Marina”. Durante il rastrellamento della Piana, il 9 settembre 1944 fu catturata dal battaglione russo di Marano, assieme a Ombretta (Maddalena Faccin), altra partigiana fissa al distaccamento. Furono portate in carcere a Thiene e sottoposte a diversi interrogatori, poi trasferite a San Biagio. Furono liberate verso i primi di novembre 1944 e dovettero nascondersi fino alla Liberazione, tagliandosi e tingendosi i capelli di colore diverso. Nei documenti ritroviamo Anita il 28 aprile 1945 a Tezze di Arzignano, quando con il fratello Inferno va armata a “rinforzare le file” del btg. Brill. Ombretta, invece, prese parte con i partigiani all’occupazione di Valdagno.
Le donne nelle Brigate. Anche se non organizzate e strutturate come nella brigata Stella, le donne sono presenti presso tutte le brigate partigiane, spesso per la semplice necessità di doversi eclissare essendo state individuate dalle polizie nazifasciste. Liliana Colombara, la staffetta Meri, operaia del lanificio Conte di Schio si nascose nel bosco, con la pattuglia di Ivan del distaccamento Barbieri. Nell’intervista ricorda che dormiva dove capitava: «a Monte di Magrè ai Casarotti, in qualche casa, nel buso, nel fieno. Portavo ordini e messaggi. Andavo al Xomo, a Monte di Malo. Andavo giù in valle, uno dei partigiani faceva la guardia e io su due sassi mettevo su un gran pentolone per la minestra. Quando veniva prelevata una bestia, siccome non c’era il frigorifero, la si tagliava in quarti e lo si dava anche agli altri distaccamenti». Filomena Dalla Palma, Gina, invece si rifugiò sul Grappa. Lei era un’operaia alla pressa alla Lancia di Cismon del Grappa e, inizialmente, con il permesso del direttore dello stabilimento portava, in un punto stabilito, ad una persona in contatto con i gruppi partigiani della montagna, una busta piena di buoni per prelevare generi alimentari.
La sua famiglia non era impegnata politicamente, ma il contatto con l’ambiente della fabbrica portò Gina a scegliere di mettere la sua vita in pericolo, per combattere per la libertà.
Avvisata da una cara amica che il suo lavoro era stato individuato, con tanto coraggio, ma grande disperazione della mamma, a piedi, con alcune amiche, tutte sorelle o mogli dei partigiani in montagna, raggiunse i garibaldini della brigata Montegrappa,sul massiccio del Grappa. Gina era armata di una vecchia pistola a tamburo a 5 colpi, portava il fazzoletto rosso e la coccarda tricolore sul petto che lei stessa aveva confezionato anche per tutti i compagni. Indossava i pantaloni perché, scrive nel suo diario, si corre meglio «e non ti impicci negli alberi».
Sul Grappa c’erano diverse partigiane, come ad esempio Idalma Rech, Mirka, garibaldina aggregata alla Gramsci, arrestata nel luglio del 1944 e deportata nel lager di Bolzano. Di alcune però non c’è sicurezza del nome, come le tre ragazze da Seren del Grappa, di cui parla Gina nel suo diario, che assieme ad altre lavoravano al Forcelleto in una sorta di sartoria messa in piedi per poter cucire capi di vestiario per gli uomini. Durante l’assalto nazifascista del Grappa, con il “Si salvi chi può” lanciato dal comando partigiano il 21 settembre, Gina riuscì a fuggire dalla montagna in fiamme insieme a Gianna Costa, Katia. Anche Be- atrice Giacconi, staffetta della brigata Matteotti, riuscì a scappare dai rastrellatori mentre il marito, il carabiniere Domenico Giacca veniva ucciso in com- battimento, ma l’attendeva un destino tragico e cru- dele nell’ottobre successivo per mano nazista. Gianna Ferrarese lavorava presso il comando della brigata Italia Libera Campo Croce, e se il partigiano Dante Perato la ricorda impegnata, agli inizi, in cucina, alla macchina da cucire e al lavatoio, secondo il fratello Nico invece: «La Gianna sì, quella era una partigiana con tanto di mitra, non era solo la cuoca dei partigiani, come dicono alcune memorie, non era solo una staffetta. […] E non l’hanno mai presa, era la «primula rossa». Lei sparava, lei colpiva, mi ricordo, le coppe di ceramica che tenevano i fili della luce. Colpi- va senza problemi, con estrema precisione. […] Lei era l’obiettivo. Ma non l’hanno mai presa. Il fatto che fosse una donna era un motivo in più di risentimento e di rabbia, anche per la mentalità di allora […] il maschilismo era parte integrante del modo di pensare dei fascisti. La donna doveva essere come mia madre che sveniva e cadeva a terra. Ma mia sorella Gianna si è sempre ribellata a questo stato di cose». Durante l’attacco del Grappa, Gianna venne vista da un partigiano allontanarsi dagli scontri armati e superare lo sbarramento posto ai piedi del massiccio dai brigatisti, mentre accompagnava Valentino Filato, ferito e zoppicante, in cerca di un rifugio. Le partigiane e l’uso della violenza. Per le donne che avevano compiuto una scelta di campo si presentò il secolare dilemma fra la rivendicazione dell’eguaglianza con l’uomo e l’affermazione della diversità, che sembrò doversi riassumere, nell’emergenza della lotta armata, nella scelta fra usare e non usare le armi. Lo sparare sui nemici era visto talvolta come una sfida vinta anche nei confronti dei propri compagni, ma spesso si trattava di una decisione consapevole. Luisa Urbani, nome di battaglia Juna, scesa dall’altopiano di Asiago, nell’ottobre del 1944, entrò nel distaccamento Mameli che aveva posto le basi nella zona di Zanè, Grumolo Pedemonte e Fara Vicentina. Fin dall’inizio ebbe l’incarico di vice commissario e come tale divenne la responsabile dell’ufficio stampa, pertanto divulgava «manifesti in tutta la zona della brigata per incitare la popolazione contro i na- zifascisti e sostenere i partigiani», ma senza rinunciare alle azioni armate. Definita «intrepida garibaldina», nel marzo del 1945 catturò «due tedeschi armati che percorrevano la strada in motocicletta» e la notte del 25 aprile 1945, al comando di una squadra di partigiani liberò Caltrano prendendo possesso del magazzino della Todt ed eliminando la resistenza repubblichina. Vi erano per contro donne che si rifiutavano di sparare e di uccidere per propria e convinta scelta. Curavano i feriti, portavano ai combattenti armi, plastico e munizioni, ma non sparavano mai. Queste donne erano probabilmente convinte del valore assoluto della vita, ma si rifiutavano di sopprimere di propria mano quella altrui. Esse, che pure avevano compiuto una netta scelta di campo, alle ragioni della lotta politica e armata non hanno sacrificato quelle della pietà. «Non sono mai stata capace neppure di tirare il collo ad un gallina» mi ha detto nella sua intervista Luigina Castagna, partigiana Dolores del btg. Romeo «se la mia famiglia avesse dovuto aspettare me sarebbe morta di fame». La sua era una scelta interiore del rifiuto di qualsiasi tipo di violenza. Mi raccontò che un giorno i partigiani le dissero: «“Questa pistola te la regaliamo per ricordo”. Io invece dopo l’ho regalata a un partigiano che era senza armi, non ho mai pensato di tenerla per difendermi perché odio le armi. Non ho mai sparato un colpo in vita mia. A Campo Davanti i partigiani volevano insegnarmi a sparare ora che avevo anch’io la mia pistola, ma io fui decisa nonostante le loro insistenze. No, le armi mai, sparare mai. Penso che per un uomo fosse più semplice essendo stato abituato già sotto le armi, infatti penso che adesso sia più semplice per una donna prendere in mano una pistola, troviamo le donne poliziotto, soldato…forse hanno più dimestichezza di una volta».
Le partigiane nei bunker. Le donne che svolgevano il loro lavoro nella Resistenza stando a casa, ovvero coloro che svolgevano il duplice o triplice ruolo di par- tigiana e di mamma/figlia/sorella e operaia/ contadina/impiegata/studentessa, nel momento in cui venivano scoperte, per sfuggire alla cattura, dovevano salire in montagna in brigata.
Come gli uomini, durante il lungo e gelido inverno del 1944-45, rimasero nascoste in rifugi chiamati bunker: «tane scavate nella terra di dimensioni varie a seconda del numero dei componenti la pattuglia, potevano essere di sei metri quadrati, di otto o di dieci, la loro altezza non superava mai il metro e mezzo di altezza. Teresa Peghin, staffetta e portaordini della brigata Stella, una ragazza che non aveva paura perché troppo orgogliosa, [«Quando facevo la staffetta non avevo paura: ero orgogliosa di fare qualcosa di importante, di prestarmi, di fare»], fu costretta a rimanere nascosta in montagna nei bunker per cinque mesi, assieme ad altri partigiani: era ricercata per aver portato 18 milioni del tempo, in denaro e assegni, da Selva di Trissino al C.N.L. di Padova, denaro che era stato prelevato dal Ministero della Marina che aveva sede a Montecchio Maggiore in seguito ad un attacco partigiano. «Catone allora, visto che ormai ero “bruciata” mi ha spedito su a Recoaro e sono sempre stata là fino alla liberazione. Tutto l’inverno l’ho passato nascosta nei “busi”. Si dormiva vestiti con solo una coperta e quando c’era la neve al mattino dovevamo strizzare le coperte perché la neve ha cominciato a sciogliersi verso aprile». In contrada Branchi Wally rimase nascosta per un periodo con Antonio Povolo, “Ortiga”, in un “buso” ricavato all’interno di un deposito di fascine di legna, al quale si accedeva da un ovile adiacente, passando attraverso un’apertura posta sotto la greppia dove mangiavano capre, pecore ed agnelli. Ma per non essere individuata cambiò spesso rifugio insieme ai suoi compagni: si nascose in contrà Balestri in una tana scavata sottoterra nella quale si entrava scendendo una scaletta nascosta dentro un gabinetto fatto di canne, ma anche in un “buco” ricavato all’interno dei muri di sostegno tra una casa e l’altra. Il rischio di venire scoperti era molto alto a causa dei continui rastrellamenti operati da fascisti e tedeschi per cui a molte partigiane divenne difficile, se non impossibile nascondersi. Teresa divideva il bunker anche con il medico dei partigiani, il dott. Gianattilio Dalla Bona, che venne catturato a Recoaro proprio davanti all’entrata del “buso” il 23 febbraio 1945, mentre lei si era recata con un’altra partigiana Virginia Zuccate, a casa della mamma di “Ortiga”, ucciso tre giorni prima, per portarle parole di sostegno e di conforto. Un giorno un’amica della contrà le dice: “Vieni con me che devo lavare la biancheria, laggiù in valle!”. Teresa prende il suo lavoro a maglia e la segue. “Siamo lì lei che lava nel fosso e io che faccio la maglia. Faceva abbastanza freddo. Lì vicino c’era un sentiero … Ci accorgiamo che c’è una pattuglia di fascisti. Io mi sono resa conto che non avrei mai fatto a tempo a scappare … Allora sono stata ferma continuando a lavorare. Un fascista mi chiede i documenti. “Mi dispiace ma non ho documenti” ho risposto “sono tutti rovinati e non me li porto dietro” era l’unica scusa che mi veniva in mente in quel momento. Mi chiesero come mi chiamavo e io pronta: “Storti Maria” che era poi la sorella della mia amica. I fascisti continuavano a guardarmi e a parlottare fra di loro. Mi chiesero se andavo mai in paese a Recoaro. “Si, qualche volta” risposi “quando ne ho bisogno”. Mi chiesero se andavo a ballare. “Magari” risposi io “che mio padre mi lasciasse andare a ballare”. Alla fine se ne andarono salutandoci e dopo avermi detto: “Beh, se dovesse andare a Recoaro a ballare avrei piacere rivederla!”. Alla mia amica non chiesero niente, neppure i documenti, ma era cambiata di colore per lo spavento. Io invece ero tranquilla. Non so, ero così incosciente a quell’età…… Appena i fascisti si furono allontanati, la mia amica mi viene a dire che mio papà e mio fratello erano stati ammazzati dai fascisti. Per questo mi aveva chiesto di accompagnarla a lavare la biancheria, perché aveva il compito di comunicarmelo”.
In realtà il fratello Pietro, ferito gravemente, riuscì a salvarsi grazie all’aiuto di una famiglia che lo nascose, ma per diversi giorni tutti pensarono che fosse stato ucciso come il padre Ettore.
Le partigiane e la tortura. Scoperte dalla delazione di spie prezzolate, ma più spesso da ex compagni e compagne passati al nemico, molte partigiane vennero incarcerate, torturate, violentate. Nel febbraio 1945, circa 150 tra uomini e donne risultavano essere stati seviziati da uomini dell’UPI della Gnr e della banda del maggiore Carità, al punto che il procuratore della Rsi, Alfonso Borrelli avviò le indagini che portarono alla raccolta di numerose denunce da parte delle vittime, ognuna accompagnata dalla perizia medica eseguita dal dr. De Megni, parte delle quali giunsero sul tavolo dello stesso Mussolini. Gli interrogatori degli arrestati venivano condotti usando le peggiori torture: mani, scarponi, bastoni, nerbo di bue, nastro cinese, fiammiferi e sigari accesi, corrente elettrica, violenze e umiliazioni sessuali. Per le donne che venivano arrestate non c’era molta scelta: o parlare e tradire per sempre i propri compagni, o non parlare, e andare incontro ad un grande dolore fisico e morale. All’inizio la scelta di non parlare è scontata, per chi lotta credendo negli ideali, ma poiché la soglia del dolore è molto soggettiva, il corpo e la psiche umana hanno limiti molto diversi da una persona all’altra. Il risultato è che moltissimi parlano: «Qualcosa bisogna pur dire» dirà Maria Gallio, perché la smettano o diano un attimo di tregua al proprio corpo lacerato dalle ferite e dalle botte o sconvolto dalle scosse elettriche o dalle violenze sessuali. «Bisognerebbe provare gli interrogatori» sostiene Wally Pianegonda, «Dalle botte ero ormai impazzita. Al mattino quando sentivo la carceriera con le grosse chiavi che tintinnavano, contavo i passi con il cuore che mi saltava in gola, man mano che aumentavano. Contando i passi, sapevo se toccava a me o a un altro. Io diventavo matta, anche due volte al giorno mi portavano via. […] Uno degli ultimi interrogatori ci portarono tutte insieme nella stanza dove assistemmo all’interrogatorio della mamma: sempre le stesse domande. Cominciarono a picchiarla con violenza. Prima sui piedi le diedero 35 cinghiate: aveva pezzi di carne che si staccavano e più tardi rischiò la cancrena. Erano colpi forti perché il torturatore si era inginocchiato per picchiare più forte. Poi la denudarono e la misero sopra un tavolo e la picchiarono con la cinghia dappertutto, sulla schiena, sulle gambe. Le misero una calza di lana in bocca perché non parlasse: lei continuava a dirci di stare zitte, di non parlare. […] Dopo ci fecero uscire, sentimmo sparare un colpo: “Adesso abbiamo ucciso la vostra mamma, siete contente?”. Ci vennero a dire che nostra madre era morta. Invece per fortuna lo avevano fatto per spaventarci. Fu portata in una cella ancora più fredda, senza pagliericcio per terra e a pane e acqua. E pensare che la neve veniva dentro dalla finestra senza vetri. Appena riuscì ad avere un po’ di forze si fasciò i piedi piagati con la sottoveste». Per delazione di un amico d’infanzia, Victor Piazza, che si era infiltrato nella brigata partigiana, Wally Pianegonda venne arrestata e portata nel carcere di Rovereto insieme alle sorelle Adriana e Noemi, alla mamma Bariola Bon Maria e a due zii materni. Quello che gli aguzzini volevano sapere da mamma e sorelle era il luogo dove si nascondeva il loro figlio/fratello Walter. Alla fine, furono internate nel campo di concentramento di Bolzano. Le donne della valle dell’Agno furono in gran parte arrestate dalla brigata nera di Valdagno, tra novembre ’44 e gennaio ‘45, per la delazione della Katia, un personaggio assai controverso. Wilna racconta nel suo diario i giorni degli interrogatori passati da lei e dalle altre ragazze a palazzo Festari: «Quando entra Dolo- res è già buio…. Dalla stanza di tortura mi giungono acutissime le grida di Dolores. A quali torture l’avranno sottoposta perché gridi in quel modo? Si odono anche le risate dei brigatisti che provengono dalla stessa stanza. Io mi sento una fredda nube di sudore sul viso e tremo, inorridisco nell’udire la mia compagna sottoposta alle torture. Due ore e mezzo dura questo supplizio. Finalmente vedo aprirsi la porta ed uscire Dolores. Tomasi uscendo dice: “Per oggi basta, domani toccherà a te Nadia preparati …”. Mi avvicino a Dolores e con lei proseguo vedo la stanza ove le tre Benetti mi at- tendono, naturalmente circondate dalla ciurmaglia che tanto s’è divertita nel vederle sottoposte alla tortura della macchinetta». Ho chiesto a molte di loro dove trovassero la forza per affrontare quei momenti. Maria Gallio mi ha risposto: «Trenta giorni a San Michele … la forza me l’hanno data le mie compagne, il mio entusiasmo con cui vivevo i miei anni giovanili pieni di speranze e ideali, la voglia di uscire da un baratro, la speranza che un giorno la causa per la quale lottavamo io e i miei amici vincesse».
La Liberazione del Vicentino 28-30 aprile 1945. Finita la guerra, nel momento della discesa dalle montagne alle piazze e delle sfilate per le strade cittadine, le donne partigiane vengono messe in coda o non sfilano affatto o le circondano l’imbarazzo e l’ironia dell’Italia tradizionalista e bacchettona, che non sono esclusivamente di una parte politica:
“Io non ho potuto partecipare alla sfilata, però. I compagni non mi hanno lasciato andare. Nessuna partigiana garibaldina ha sfilato. Mi ricordo che strillavo: “Io vengo a ficcarmi in mezzo a voi, nel bello della manifestazione! Voglio vedere proprio se mi sbattete fuori”. “Tu non vieni, se no ti pigliamo a calci in culo! La gente non sa cos’hai fatto in mezzo a noi, e noi dobbiamo qualificarci con estrema serietà”. Così alla sfilata ero fuori, in mezzo alla gente, ad applaudire. Ho visto passare il mio comandante, poi ho visto il comandante Mauri con i suoi distaccamenti autonomi e le donne che avevano combattuto. Loro sì, che c’erano. Mamma mia, per fortuna non ero andata anch’io! La gente diceva che erano delle puttane”. Il racconto è di Trottolina, e si riferisce al 1° maggio di Torino. Ma non mancano testimonianze simili dalle città emiliane: si verificò già all’indomani del conflitto una pronta espulsione, sia materiale che mentale, delle donne dal movimento della Resistenza. “Dirò che finita la guerra noi donne siamo state tanto offese” ha sostenuto Alberta Cavaggion “Io sono stata fortunata che ho trovato un marito meraviglioso, con il quale non ci sono stati problemi. Ma io dovevo essere l’amante di questo, l’amante di quello […] per me era un’offesa da chiarire”. Le partigiane da attrici, anzi artefici della liberazione, diventano spettatrici, tra il pubblico che applaude, scruta e mugugna, dei liberatori che si esibiscono festanti sulle strade. Dalla visibilità del conflitto le donne tornano a scomparire tra l’anonimato della folla. Eppure, diversamente da tante altre città, a dispetto della morale bigotta, in quei giorni a Valdagno il battaglione Amelia sfilò, in divisa insieme a tutti gli altri reparti partigiani combattenti, al campo sportivo, in occasione dei festeggiamenti e le donne di Recoaro, sedute su un carro agricolo per il fieno, erano arrivate tutte insieme a Valdagno. Da piccole fotografie, relegate nelle vecchie scatole in fondo agli armadi, sono emerse le istantanee di giovani uomini e donne, l’uno a fianco all’altra, spesso entrambi in divisa e armati. Pezzi di vita custoditi gelosamente nei quali le ragazze partigiane sono sorridenti e a testa alta esprimono tutto il loro orgoglio della scelta di aver partecipato alla Resistenza. Il sorriso di alcune è però offuscato dalla tristezza e dal dolore che custodivano nel loro cuore. “Adesso abbiamo raccontato la nostra storia” mi hanno detto Wally e Adriana Pianegonda, al termine dell’intervista, in un unico racconto a due voci “ma è difficile comunicare quello che noi abbiamo sofferto …entrare nel campo di concentramento di Bolzano ha significato la liberazione, la liberazione da un incubo …eppure mi sentivo sola, completamente sola e costretta a diventare adulta tutto in un momento … avrei voluto essere io l’artefice della mia vita …invece mi sono trovata in balia di esseri mostruosi. Eppure…se dovessi tornare indietro la mia esperienza non la venderei a nessuno…avevo un ideale che mi sosteneva…
ho pagato a caro prezzo la fede in un ideale giovanile, ma alla fine mi sono sentita ricca dentro …la libertà che abbiamo conquistato per noi, per le generazioni che sarebbero venute ci ha ripagato di tutta la nostra sofferenza”.
Di Sonia Residori da Storie Vicentine n. 2 Aprile maggio 2021